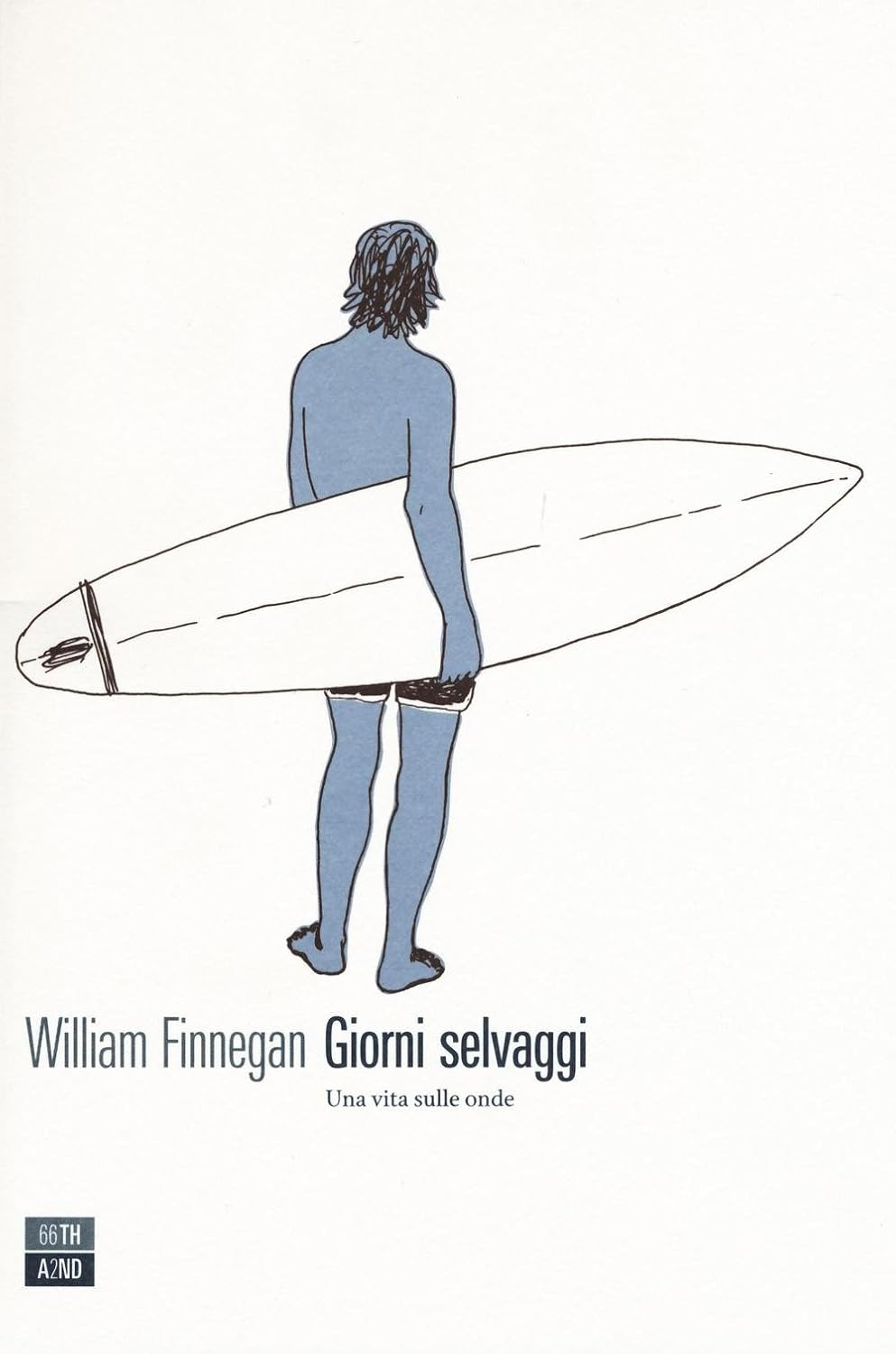flint#03 - Barbarian days
"Ora sono anch'io tra quei newyorkesi sempre sul punto di tornare da dove vengo. Ma per me non si tratta di fare le valigie o di restare dove sono, piuttosto di essere sempre quasi pronto ad abbandonare la mia scrivania e i miei impegni gravosi per gettarmi in un pezzo di oceano dei dintorni, nel momento in cui le onde e il vento e la marea potrebbero concorrere a produrre qualcosa di surfabile. Quell'angolo meraviglioso ed effimero è il luogo da cui vengo." William Finnegan, Giorni selvaggi SommarioInformazione di servizio: tutte le newsletter sono disponibili a questo link (qualora vi siate persi le precedenti o vogliate in futuro leggerle nuovamente se non le trovate nella casella di posta). Oggi si inaugura una nuova rubrica nei "Consigli".
Libri che cambiano una vita - Giorni selvaggi di William Finnegan
Ho letto questo libro durante la pandemia. Lo avevo visto spesso in giro nelle librerie ma non lo avevo mai considerato fino a quando probabilmente la necessità di uscire di casa, almeno mentalmente, ha preso il sopravvento, letteralmente. Questo è un libro emozionale ed intenso, che ti porta via come un'onda forte. "Nel surf c'era sempre questo orizzonte, questa linea del terrore, che lo rendeva diverso da qualsiasi altro sport, di sicuro da quelli che conoscevo io. Potevi anche praticarlo insieme agli amici, ma quando arrivavano le onde grosse, o ti trovavi nei guai fino al collo, sembrava che non ci fosse mai nessuno lì a darti una mano. In mare, ogni cosa è legata in modo indissolubile e inquietante a tutte le altre. Le onde sono il campo da gioco. Il fine ultimo. Sono l'oggetto dei tuoi desideri e della tua ammirazione più profonda. Allo stesso tempo, sono anche il tuo avversario, la tua nemesi, il tuo nemico mortale. L'onda è il rifugio, il tuo nascondiglio felice, ma anche un territorio selvaggio e ostile, una realtà indifferente e dinamica. A tredici anni, avevo smesso in pratica di credere in Dio, ma questo nuovo sviluppo aveva lasciato un vuoto nel mio mondo, la sensazione di essere stato come abbandonato. L'oceano per me era simile a un Dio insensibile, infinito nella sua pericolosità, dotato di un potere smisurato."¹ Giorni selvaggi è un memoir di William Finnegan che racconta la sua vita in prima persona, tra autobiografia, riflessioni esistenziali e sociali, surf (tanto surf) e avventura. Ha vinto il premio Pulitzer nel 2016 con questo libro, anche se onestamente l'ho scoperto dopo averlo letto la prima volta. Lo stile di scrittura è tipicamente anglosassone, a tratti giornalistico e tecnico (quasi gergale) nel descrivere il surf in tutti i suoi aspetti. Allo stesso tempo è molto intimo quando si apre totalmente al lettore, con riflessioni profondamente umane e non posticce da manuale da due soldi di auto-aiuto. Seguiamo insomma il corso della vita dell'autore dal suo punto di vista e della sua evoluzione umana tramite il viaggio e il surf. Il surf insomma è un mezzo per conoscere il mondo, per assaporarlo fino al midollo. Per non fermarsi mai. "Poco per volta iniziavo a orientarmi a Honolulu. Dalla lineup dei Cliff si riusciva a vedere l'intera costa meridionale di Oahu da ovest a est, dalle montagne di Waianae a Honolulu e Pearl Harbor, fino a Koko Head, una specie di Diamond Head più accessibile - un altro cratere riarso in riva al mare. La città copriva la pianura tra la costa e la montagna di Ko'olau, le cui cime verdi e scoscese erano perlopiù coperte da nuvole e foschia, e sovrastate da luminose nubi temporalesche. Le montagne inviavano le nuvole cariche di pioggia a bagnare la città, anche se gran parte si dissolveva prima di raggiungere la costa. Il cielo era cosparso di arcobaleni. Oltre le montagne, in lontananza, si estendeva il piovoso versante sopravvento, e da qualche parte, in quella direzione, c'era la leggendaria North Shore."¹ Finnegan vive il surf in maniera maniacale, è il pensiero fisso la mattina appena sveglio e la sera prima di andare a dormire. Risulta essere per lui una malattia, sicuramente un'ossessione. A mio avviso però questa lettura, per quanto corretta, potrebbe risultare abbastanza superficiale e riduttiva. Per il Finnegan bambino nelle sue prime esperienze alle isole Hawaii, il surf è lo strumento di condivisione con la popolazione locale, per conoscere coetanei, per mettersi alla prova e per vivere veramente in mezzo all'oceano Pacifico. Il surf non è il fine. Il surf è il mezzo, il medium fatto di legno per fare esperienza della natura divina. "Nelle antiche Hawaii, prima che arrivassero gli europei, il surf aveva un'importanza religiosa. Dopo le preghiere e le offerte, i mastri artigiani fabbricavano le tavole con il legno sacro di koa o con l'albero wiliwili. I sacerdoti benedivano le mareggiate, sferzavano l'acqua con i rampicanti per invocarle, e alcuni break avevano heiaus (templi) sulla spiaggia, dove i fedeli potevano pregare per l'arrivo delle onde. [...] Surfavano tutti, uomini e donne, vecchi e giovani, i reali e la gente comune. Se le onde sono buone, «il pensiero del lavoro svanisce, e rimane solo quello dello sport», scrisse un intellettuale hawaiano dell'Ottocento, Kepelino Keauokalani. «Tutto il giorno non c'è altro che il surf. Molti escono in mare già alle quattro di notte». In altre parole, gli antichi hawaiani avevano la febbre del surf."¹ Nell'immaginario comune il surf è per ribelli ed è sempre avvolto da quell'aurea di fascino lontano con spiaggie caraibiche, tramonti mozzafiato e freschezza giovanile dai capelli lunghi. Diciamo che questo libro abbatte questa visione stereotipata perché Finnegan è una persona "normale", nel senso che vive il surf non come un'idea che ho in testa di quanto è bello e figo essere surfisti agli occhi degli altri. Lui l'ha vissuta fin da bambino come unica via per conoscere il mondo e soprattutto per conoscere sè stesso. In maniera molto concreta, sulla sua pelle in ogni parte del mondo. Questa sua autencità viene galla e resta presente durante tutto il libro. Considerando che il suo autore è nato nel 1952, è piacevole leggere una storia di una vita appassionata non influenzata dai trend del momento o dall'esibizione di qualcosa tramite i social media. Rimane un memoir e perciò un certo grado di esibizione c'è ma non è intriso dal mantra moderno "esisto perché mostro". Fateci caso: se non mostrate a qualcuno o sui social una foto di un viaggio, quel viaggio che comunque avete fatto potrebbe risultare sminuito o addirittura portare a pensare che quel viaggio non sia mai avvenuto. Ecco, Finnegan non ha mai surfato per i like. Finnegan ha sempre surfato in primis per quell'amore e ossessione per le onde. "Non era certo questo lo stile di vita che i missionari calvinisti avevano in mente per gli isolani quando arrivarono alle Hawaii, nel 1820. Hiram Bingham, il capo della prima spedizione evangelizzatrice, si ritrovò in mezzo a un'orda di surfisti addirittura prima di sbarcare, e scrisse che «quell'immagine di sfinimento, di degradazione e di barbarie, tra quei selvaggi ciarlieri e seminudi con la testa e i piedi scoperti e gran parte della pelle bruna riarsa dal sole, era agghiacciante. Alcuni di noi, con gli occhi traboccanti di lacrime, allontanarono lo sguardo da quello spettacolo». [...] Dopo la guerra, la California del Sud divenne la capitale della nascente industria del surf in seguito allo sviluppo improvviso dell'ingegneria aerospaziale, che fornì sia nuovi materiali ultraleggeri per fabbricare le tavole sia una generazione sterminata di ragazzini come me, con il tempo e la voglia di imparare a surfare. Non che le autorità locali ci incoraggiassero, tutt'altro, i surfisti erano bollati come teppisti e scansafatiche. Alcune cittadine balneari erano perfino giunte a vietare il surf. E lo stereotipo del surfista solitario - fratello dello sciatore solitario, del navigatore solitario, dello scalatore solitario - non è mai passato di moda, e per ragioni sacrosante. Oggi, personaggi come Jeff Spicoli, il surfista strafatto impersonato da Sean Penn nel film Fuori di testa, vivacchiano un po' ovunque nelle località di mare in giro per il mondo. Ma le Hawaii erano diverse. Se non altro, lo erano per me. Il surf non faceva parte di una sottocultura importata o contro il sistema, per quanto la sua stessa sopravvivenza rappresentava l'opposizione più duratura ai valori della borghesia calvinista incarnati da Hiram Bingham. Il surf era un elemento irrinunciabile del tessuto sociale."¹ A me a volte ha trasmesso anche una sensazione strana, ossia di una vita raccontata inseguendo onde e scappando da tutto il resto. Finnegan parte dall’adolescenza tra California e Hawaii, passa per il Texas e la costa Est degli Stati Uniti, poi allarga l’orizzonte fino a trasformare il surf in una bussola esistenziale che lo porta in Australia, Nuova Zelanda, Indonesia (soprattutto Bali), Sri Lanka, Sudafrica, Ghana, Senegal, Liberia, Togo, Benin, Fiji, Tahiti, Samoa, Tonga, Giappone, Perù, Messico, Brasile, El Salvador, Francia, Portogallo, Spagna e di nuovo negli Stati Uniti, tra San Francisco, New York e Los Angeles. Non sono semplici tappe esotiche, ma luoghi vissuti fino in fondo, spesso ai margini, tra villaggi poverissimi, tensioni politiche, razzismo, violenza e momenti di grazia assoluta in mare. "Chiamatelo pure un inverno senza fine. L'estate rientra nell'iconografia popolare del surf. E come molta di quella iconografia è sbagliata. Un po' ovunque, a nord o a sud dell'equatore, la maggior parte dei surfisti vive per l'inverno. È il periodo in cui si scatenano le burrasche più forti, di solito alle latitudini più alte, e in cui si producono le onde migliori. Ci sono alcune eccezioni - tra cui, a proposito di iconografia, Waikiki e Malibu -, ma l'estate è spesso avvilente per i surfisti. Un'eccezione che mi aveva incuriosito a lungo era la stagione dei cicloni estivi nel nord-est dell'Australia. Ma quando nel 1978, all'inizio della primavera, lasciai Los Angeles con una tavola da surf, una tenda e una pila di cartine nautiche della Polinesia, studiate con estrema attenzione, era l'inverno che stavo cercando. Partire non era così semplice. Avevo un lavoro che amavo. Avevo una ragazza. [...] Ma in banca avevo cinquemila dollari, la somma più grossa che fossi mai riuscito a mettere da parte. Avevo venticinque anni e non ero mai stato nei Mari del Sud. Era tempo che mi concedessi un viaggio serio per fare surf, lanciandomi in una caccia infinita alle onde. Questo viaggio era una specie di tappa obbligata. Avrei puntato per sempre a ovest, come Magellano o Francis Drake - secondo il mio punto di vista, almeno. A dire il vero, per quanto fosse difficile, levare le tende era molto più facile che rimanere, per più di un motivo. Era un'occasione unica per rimandare alcune scelte banali ma terrificanti su dove e come vivere. Sarei scomparso da quel mondo super regolato e deludente, intorpidito dalle discoteche e dalla crisi energetica in cui era precipitata l'America. Forse agli Antipodi sarei diventato un'altra persona - qualcuno che mi piacesse di più."¹ Il cuore del libro sta lì: nella tensione costante tra il desiderio di restare fedeli a una passione totalizzante e la realtà che avanza, tra ideali giovanili e la vita adulta che chiede il conto. Finnegan scrive con lucidità e senza romanticismi inutili, raccontando anche il lato ossessivo, elitario e a volte ridicolo del surf, ma senza mai rinnegare ciò che lo ha formato come persona e come scrittore. Giorni selvaggi è un libro sull’educazione sentimentale di un uomo che non ha mai smesso di misurarsi con qualcosa di più grande di lui, sapendo che perderà quasi sempre ed è proprio questo il punto. Il surf misura il tempo che passa di qualcuno che ha visto mezzo mondo restando spesso fuori posto, e che ha capito presto che crescere non significa smettere di inseguire le onde, ma accettare il prezzo di continuare a farlo. "Le onde continuavano a riversarsi, lucenti e misteriose, diffondendo nell'aria un'austera esaltazione. Inia splendeva nel suo ardore di surfista e di predicatore. Avevo ancora dei dubbi? «Perciò noi non temeremo, quantunque la terra si tramutasse di luogo, e i monti smossi fosser sospinti in mezzo del mare; E le acque di esso romoreggiassero, e si intorbidassero». Continuavo ad avere dei dubbi. Ma non avevo paura. Volevo solo che non finisse mai."¹ Voglio inseguire le onde come William Finnegan, ovunque esse mi porteranno.
Street art - Arte per tutti, di tutti e da tutti
Ariel Ocampo dipinge su un freddo cavalcavia a Córdoba (Argentina) un bambino vestito da colibrì che giocando trasforma il mondo che osserva in un paesaggio colorato e vibrante, pieno di vita. Dal cemento sbocciano fiori e colori dove i veri colibrì arrivano per il dolce nettare. Ecco cosa possiamo creare tramite l'arte e i colori nelle città. L'immaginazione e la forza creativa dell'infanzia ci dimostrano come anche un anonimo pezzo di strada possa portare gioia alla collettività. Ho avuto la fortuna di vederlo dal vivo e vi assicuro che le foto non rendono giustizia a questa radiosa opera. Il consiglio - Qualcosa di bello di InternetOggi mi permetto di consigliarvi due siti web che fanno parte di quell'Internet che ormai non esiste quasi più. Ossia quell'Internet privo di interessi commerciali ma stracolmo di cose stravanganti fatte solamente per il gusto di farle e condivise nell'etere.
⚓ Naviga con me tra parole e idee: iscriviti a flint Se questa newsletter ti è piaciuta, sentiti libero/a di inoltrarla: più siamo a bordo, meglio navighiamo. 🌊 Se ti sei perso o vuoi recuperare tutte i numeri di flint usa questo link! "Non esiste miglior barca di un libro per esplorare terre lontane." Emily Dickinson
|